Avvicinare, fare leva sull'ultimo, semplificare. È quello che chiamerei "lo schema Francesco", la struttura di fondo che ha adottato Papa Bergoglio nel suo modo di comunicare durante il suo pontificato.
Lo so, dicendo "schema" potrei subito suscitare due obiezioni, opposte. La prima dei difensori, che potrebbero dirmi: "non era una tattica, era autentico". La seconda dei detrattori: "è vero era una tattica, ma inefficace: ha creato confusione sulla sostanza".
Le raccolgo entrambe e le riunisco in una battuta a me molto cara: "le cose più spontanee sono quelle meglio preparate". Intendo, cioè, che non esiste per forza una dicotomia tra autenticità e strategia. Chiunque, per dire quello che veramente vuole dire, ci deve pensare e lo deve elaborare, altrimenti non riesce a esprimersi autenticamente. E poi la forma è sostanza: quella che alcuni chiamano confusione o ambiguità, potrebbe essere la scelta consapevole di non lasciare indifferente nessuno.
Le tre leve (più una) dello "schema Francesco"
Ora, come procede "lo schema Francesco"? Applica in modo virtuoso alcune leve di persuasione. Vere e proprie virtù della comunicazione capaci di attivare relazioni significative e muovere il pensiero.
La prima è la leva della prossimità: dire qualsiasi cosa ponendola come vicina agli interlocutori. Che possano toccare e sentirsi addosso ciò che dici. Bando alle astrazioni, al concettualese, ai paroloni. Sì alle parole comuni, alle immagini facili, a ciò che rientra nell'immaginario di chi ti ascolta. Ciò che è vicino è familiare e convince. Ciò che è distante perde mordente.
La seconda è la leva dell'ultimo: che le parole contengano sempre la difesa di un debole contro un forte, la denuncia di un sopruso, la preoccupazione per chi non può difendersi da solo. "Stai sempre dalla parte di Davide, mai di Golia", la riassumerei così, tanto per usare un'immagine biblica.
La terza leva è quella della semplificazione: evidenzia ciò che è rilevante per dare a chi ti ascolta la possibilità di poter capire un concetto complesso con i suoi strumenti. Non presupporre conoscenze e competenze che non ha il tuo interlocutore. Un'idea che si riesce ad abbracciare è convincente, una complicata o difficile respinge.
C'è un quarto elemento, che più che una leva è un effetto. Il dissenso: generare con le parole una discrepanza tra ciò che di solito uno si aspetta o pensa abitualmente, per avviare un ulteriore passaggio, dando la possibilità di ragionarci su e discuterne ancora. Il dissenso muove il pensiero e il convolgimento, il consenso lo esaurisce in un like o un applauso.
Vediamo ora come, a mio avviso, il Papa ha messo a frutto queste virtù in alcune delle sue espressioni rimaste memorabili.
“La Chiesa in uscita, andare nelle periferie”
- Prossimità: rimanda all'idea di uscire dai palazzi per ridurre le distanze con chi "sta fuori", trasmette un senso di “cammino” che attraversa strade, piazze, luoghi del mondo.
- Leva del debole: l’asse si sposta dalla sicurezza interna verso i confini, si privilegia chi vive alle periferie (migranti, poveri, esclusi) rendendolo soggetto e non oggetto dell'azione della Chiesa.
- Semplificazione: tre parole associate - “Chiesa”, “in uscita", "periferie" - condensano in breve la parte rilevante di un progetto molto più complesso e articolato di Chiesa.
- Dissenso: ha creato dibattito dentro la Curia e tra i fedeli sul modello stesso di azione ecclesiale, stimolando un confronto sul “dove” e “come” essere Chiesa oggi.
“Una Chiesa povera per i poveri”
- Prossimità: la ripetizione “povera” e “poveri” è uno schema retorico efficace, fa visualizzare i poveri e rimanda a una Chiesa con caratteristiche simili, che agisce per loro.
- Leva del debole: la forza è nell’accoglienza del povero (Davide), non nel potere di chi sta in cima alla gerarchia (Golia).
- Semplificazione: in una pennellata un'idea di Chiesa al cui centro c'è chi è in condizione di svantaggio, a pensarci bene la parte rilevante di un progetto piuttosto complesso da realizzare.
- Dissenso: ha sollevato questioni sulla definizione di "povertà" e di contro sul concetto di "Chiesa ricca" presente nell'immaginario della gente.
“Il pastore deve avere l’odore delle pecore”
- Prossimità: l’immagine del pastore che si sporca e si impregna dell’odore delle pecore rimanda al vivere e “sentire” la vita quotidiana dei fedeli.
- Leva del debole: è un capovolgimento dell’idea di pastore “superiore”, la vera autorità nasce dall’umiltà di chi si mescola ai più deboli.
- Semplificazione: sul tema complesso del ruolo del pastore evidenza il punto rilevante di quella che potremmo chiamare empatia pastorale.
- Dissenso: ha spinto a ragionare sui confini tra autorità e servizio, sul pastore come guida o pastore come compartecipe del cammino di chi guida.
“La terza guerra mondiale a pezzi”
- Prossimità: "guerra mondiale" è un concetto che tutti sentono vicino, la "terza" a "pezzi" sottolinea che la guerra è già qui, frammentata in ingiustizie sparse nel mondo.
- Leva del debole: l'idea di "pezzi" rimanda immediatamente alle vittime silenziose dei conflitti “minori” (popolazioni affamate, migranti di guerra), chiedendo di guardarli come veri protagonisti della storia.
- Semplificazione: una frase che riesce a far abbracciare il fenomeno complesso e variegato dei conflitti nel mondo evidenziando ciò che è rilevante: quelli che dimentichiamo.
- Dissenso: ha smosso opinioni e istituzioni su terrorismo, sanzioni e flussi migratori, suscitando anche critiche da parte di chi teme di abbassare il livello di allerta.
“La globalizzazione dell’indifferenza”
- Prossimità: un ossimoro efficace, globalizzazione (fenomeno ampio) vs indifferenza (atteggiamento personale), che rende vicino il fenomeno.
- Leva del debole: rivolge l’attenzione verso chi resta invisibile nei grandi flussi economici e mediatici, scavando nella coscienza individuale per far emergere una responsabilità comune.
- Semplificazione: la "globalizzazione" nell'immaginario è un concetto complesso che rimanda al diffondersi di abitudini e stili di vita a livello mondiale, tra questi rende rilevante l'indifferenza.
- Dissenso: stimola a misurarsi con il tema dell'attenzione e della disattenzione a livello globale, soprattutto dei fenomeni considerati spesso marginali.
“La Chiesa ospedale da campo”
- Prossimità: l’analogia con un ospedale da campo – struttura spartana, vicina al fronte – esplicita in modo immediato modalità e priorità di intervento.
- Leva del debole: è una dichiarazione d’intenti verso il povero, il malato, lo scartato: il ferito è il criterio con cui misurare la presenza ecclesiale.
- Semplificazione: raffigura un'idea precisa di Chiesa non come istituzione dallo splendore intoccabile, ma come luogo di cura immediata per i feriti della vita.
- Dissenso: ha sospinto molti a ripensare il rapporto tra dottrina e pastorale.
“La corruzione spuzza”
- Prossimità: una sola parola – spuzza – rende immediatamente l’idea di schifo e rigetto verso ogni malaffare.
- Leva del debole: difende chi subisce il sopruso, dando voce ai poveri e agli onesti schiacciati dal sistema corruttivo.
- Semplificazione: la corruzione da percepire come un’offesa intima e non come un astratto illecito amministrativo.
- Dissenso: ha costretto molti a guardare con occhi nuovi i processi interni, chiamando in causa trasparenza e responsabilità.
“Non ci possiamo permettere di stare senza misericordia: è l’aria da respirare”
- Prossimità: mette la misericordia alla stregua di un bisogno primario, come l’aria, dunque universale e indispensabile.
- Leva del debole: la misericordia è il criterio che salva dal giudizio i più fragili, trasformandoli da emarginati in protagonisti di salvezza.
- Semplificazione: la similitudine con l’aria sostiene che alla base della vitalità della fede c'è il perdono: chi non respira misericordia non vive.
- Dissenso: spinge a interrogarsi sulla questione dei codici, delle regole e delle procedure, al rapporto tra logica del perdono e rigore.
Il calore del “come”, il valore del silenzio e dei gesti
Oltre a queste leve c'è molto di più. Ad esempio, più ancora delle parole, colpisce il tono di Papa Francesco: confidenziale, diretto, mai drammatico. La sua voce – a volte velata da un sorriso, altre da un’afflizione autentica – comunica calore umano, invita all’ascolto. Insomma, qui c'è il tema del "come" che conta tanto quanto il "cosa".
E poi c'è l'assenza di parole. Il silenzio nei momenti di preghiera o nelle pause dopo una frase "forte". Ma soprattutto i gesti: abitare a Santa Marta, l'uso di un'auto utilitaria, il finestrino aperto della macchina nel viaggio in Brasile, le telefonate alla gente comune, baciare i piedi dei leader africani in guerra.
Anche qui è possibile ritrovare: prossimità, leva dell'ultimo, semplificazione e dissenso. Secondo uno "schema" che, a mio avviso, è tale solo negli occhi dell'analista. In Papa Francesco era semplicemente il suo modo di vivere.




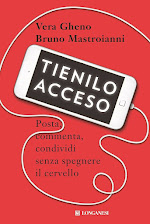



Social Plugin