(rielaborato da "Storia sentimentale del telefono", Il Saggiatore)
Non è solo una questione di sana informazione, ma di sane relazioni. Ognuno di noi stabilisce con le informazioni vere e proprie relazioni personali. Le amiamo, le odiamo. Le accogliamo o le respingiamo. Ci interessano o ci annoiano. Le capiamo o ci sembrano astruse. Ci danno gioia o ci intristiscono. Ci stanno simpatiche o le rifiutiamo a pelle. Ci fanno sentire intelligenti o ci umiliano.Non esiste un monte di informazioni in sovraccarico su cui affacciarsi asetticamente per discernere, esiste piuttosto un liquido amniotico di contenuti in cui siamo immersi, e quel liquido ci nutre e ci indebolisce, assume la nostra forma e noi a nostra volta gli diamo forma con le nostre interazioni. È in base a queste relazioni che siamo portati a considerare o meno certe informazioni, a farle entrare nel nostro brodo o a tenerle alla larga come se fossero gocce estranee in esso insolubili.
Gli algortimi delle piattaforme sono esperti proprio di queste relazioni e cercano di presentarci i contenuti rispondendo al meglio a esse. In poche parole, il problema non è solo intellettuale ma anche emotivo. Non basta avere in tasca un oracolo digitale intelligente pronto a darci tutte le risposte, perché la questione ha a che fare soprattutto con il desiderio e la voglia di farsi domande. Cosa dovrebbe spingere, infatti, un Homo sapiens a rivedere in modo critico ciò che già sa, se quel sapere gli permette di vivere bene con sé stesso e con gli altri?
Il sovraccarico di giudizi
È qui che il sovraccarico, che visualizziamo soprattutto come informativo, assume un’altra dimensione: quello delle valutazioni e dei giudizi. Le relazioni che costruiamo con le informazioni non sono condotte da ciascuno in modo impersonale, ma hanno sempre una via di entrata. C’è sempre qualcuno che ci mette in contatto e ci fa entrare in un certo rapporto con loro, come succede nelle relazioni umane, quando ci viene presentato un nuovo conoscente o una nuova conoscente da un amico o un’amica.
Facciamo entrare un nuovo elemento nel «nostro giro» in base a come ci viene presentato, a dove avviene l’incontro, all’impressione che ci suscita e soprattutto riferendoci a chi ce lo ha fatto conoscere. Insomma, con le informazioni facciamo la stessa operazione che compiamo con le persone: le ammettiamo o meno nel nostro brodo amniotico in base all’insieme di giudizi – spesso pregiudizi – che abbiamo su di noi, sugli altri, sulle possibili conseguenze sulla nostra vita, sui valori che sono più o meno rispettati da esse. Lo sanno bene gli “inquinatori” del dibattito pubblico. Fanno leva proprio su questo lato relazionale per aggirare il più possibile quello razionale.
Non ci sono le informazioni da una parte e noi dall’altra. Ci sono, invece, esseri umani che sostanzialmente giudicano altri esseri umani usando le informazioni alla bisogna. Il digitale, nella sua versione smart, non ha fatto altro che entrare in questa dinamica vecchia come l’uomo e potenziarne gli effetti, mandando in sovraccarico non solo la quantità di informazioni, ma soprattutto quella delle valutazioni e dei giudizi.
Impossibile alleggerire...
Allora, se non basta spegnere lo strumento, se non è alla nostra portata modificare la forma che i grandi della tecnologia hanno dato all’ambiente digitale, a noi rimane la parte più importante: dare un senso alle relazioni digitali in cui siamo immersi.
Qui c’è un punto cruciale in cui, per l’ennesima volta, corriamo il rischio di seguire una visione ideale e distante dalla realtà: pensiamo che se dobbiamo rispondere a un sovraccarico, la cosa migliore da fare sia alleggerirlo. Se le informazioni sono troppe, se siamo troppo esposti ai giudizi, se siamo invischiati in troppi scontri, allora dovremmo lavorare su quel «troppe» per ridurlo.
È a dir poco un’operazione titanica, impossibile da realizzare per un essere umano. Assomiglia a voler svuotare il mare con un cucchiaino o, peggio, a voler asciugare gli scogli in mezzo alle onde. Chi davvero potrebbe essere nelle condizioni di ridurre il marasma digitale di connessioni, notifiche, contenuti, interazioni, pagine web, messaggi, podcast, database online, email, che riceve costantemente? Sarebbe un lavoro talmente impegnativo da non permettere altra azione nella vita se non quella di stare lì a filtrare il rumore proliferante per renderlo segnale.
...allora "dare peso"
Il da farsi è l’opposto, attraverso un’operazione apparentemente contro-intuitiva. Invece di alleggerire, occorre dare peso. Invece di ridurre, bisogna approfondire. Invece di silenziare, conviene attivare il volume.
Chiederci, come in una sana relazione, cosa mi dà e cosa mi toglie? Con chi mi sto accompagnando? Cosa manca? Incominciare a soppesare la risultante di ciò che ci appare quando scorriamo sul touch screen. Dimmi come è la tua timeline e ti dirò chi sei: è il primo passo per prendere delle decisioni su cosa vogliamo ottenere in quei momenti di scrolling.
Per il carico di giudizi, ci verrebbe spontaneo pensare che “essere giudicati meno” sia la soluzione, ma in realtà è il contrario: è proprio l’essere pronti a vivere di giudizi e tra i giudizi che ci può far maturare molte cose interessanti. Dovremmo dare ancora più peso ai giudizi che riceviamo e che emettiamo, farci carico dell’onere di soppesare quelle valutazioni argomentando ed esplicitando le idee e le ragioni che li sostengono (o notare la loro assenza). In un mondo di giudizi sparati superficialmente, la cura non è la sospensione del giudizio, ma la presenza di giudizi di profondità ben argomentati: quelli che danno a ciascuno la possibilità di ribattere, di rispondere e di difendere le proprie ragioni.
Così si arriva al carico delle discussioni. In molti oggi sono pronti a dire che, tutto sommato, il dissenso ci fa male e che ci vuole consenso. È esattamente questa ipertrofia del consenso che genera le guerre in rete. Branchi di persone che la pensano allo stesso modo che si scagliano contro gli avversari in una perfetta contrapposizione bilanciata, in cui ognuno rafforza il consenso con gli omogenei e acuisce il disconoscimento degli eterogenei. Di fronte a queste casse di risonanza sorde al dialogo, l’unica cura possibile è proprio quella del dissenso: cercare, cioè, sempre un po’ di differenza nel simile, un po’ di obiezione nell’accordo, per vedere se le idee reggono.
Dare un peso a ciò che si legge, assumersi l’onere di argomentare i giudizi, essere pronti a cogliere le contraddizioni e il dissenso. È questo atteggiamento mentale che inserisce un po’ di sana vigilanza razionale nel lavorare sulle proprie relazioni con le informazioni.
Obiezioni
Si obietterà: “dar peso” selettivo alle informazioni implica un onere cognitivo che non tutti sono nella condizione di sostenere. Mentre alcuni possono permettersi di analizzare e valutare criticamente una mole di giudizi e opinioni, per altri – in contesti di stress o mancanza di strumenti critici adeguati – questo approccio può aggiungere ulteriore complessità, favorendo l’apatia o il ritiro dall’interazione critica con il mondo informativo.
E io aggravo l'obiezione: non solo onere cognitivo, ma anche onere relazionale ed emotivo. È un peso che, anche se non tutti sono disposti o pronti a farsene carico, ci sarà comunque. Pensare di alleggerirlo è illusorio. Proprio per questo c'è lo scrolling infinito.




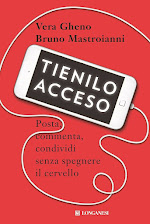



Social Plugin